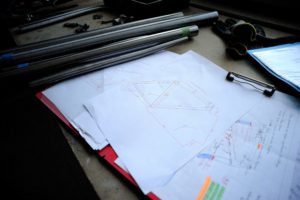La settimana scorsa eravamo andati a visitare, dentro l’università Federico II, la stanza del professore. Cioè eravamo partiti dal centro, da quello che, principalmente, era diventato da adulto. Oggi andiamo a cercare la sua prima casa, quella nella quale è nato, dov’è stato bambino, villa Caccioppoli, ncopp Capodimonte.
La principale traccia oggi ce la dà un libro (Gatto, Rigatelli: Renato Caccioppoli, nei Riferimenti). Dentro c’è la fotografia dell’Atto di nascita, che dice:
l’anno millenovecentoquattro, Avanti di me Avvocato … Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Napoli San Carlo è comparsa Elena Papazafiropulo di anni ventinove, levatrice … la quale mi ha dichiarato che alle ore antimeridiane dieci e minuti trenta, del dì venti del corrente mese (gennaio, ndr), nella casa posta in Via Capodimonte numero Villa Caccioppoli da Giulia Sofia Bakunin fu Michele d’anni trentaquattro Dottoressa moglie di Giuseppe Caccioppoli fu Domenico d’anni cinquantuno Medico Chirurgo seco lei convivente è nato un bambino che ella mi presenta, e a cui dà i nomi di Renato Ciro Agostino. La dichiarante à [sic] denunciata la nascita suddetta per avere nella sua qualità assistito al parto della Bakunin ed in luogo del marito di questa perché impedito.
Bene, allora abbiamo un certo numero di informazioni:
La mamma, Bakunin di cognome, era di origini russe, anzi era proprio la figlia* di un russo anarchico famoso: Michail Bakunin, uno che non stava mai fermo in un posto, ha vissuto in mille città. Solo a Napoli, eccezione, ha trascorso due anni (1865-1867), tempo lunghissimo per lui, gli piaceva la gente ed il caffè della nostra città, era qui dicono che ebbe la sua definitiva maturazione anarchica e ci stava per tornare, se non fosse morto. La mamma, Giulia Sofia, si era diplomata al liceo Umberto ed era stata la seconda donna a laurearsi in medicina all’università di Napoli. Il padre era un chirurgo molto noto, professore agli Incurabili. (Poi, tra parentesi: il cognome della levatrice è impronunciabile e Caccioppoli, sono andato a vedere, era capricorno ascendente ariete).
Poi, riassumendo le informazioni più utili per oggi: l’indirizzo della casa è via Capodimonte, numero civico Villa Caccioppoli. Un numero civico un poco strano, ma evidentemente all’epoca era sufficiente per individuare il luogo, per fare arrivare la posta a destinazione.
Prima di partire guardo su internet, sulla mappa elettronica del mondo: via Capodimonte non è lunga, però di ville con quel nome di tracce non ce ne sono. Forse ha cambiato nome, l’unica cosa è provare sul campo.
La ricerca sul posto
Scendo dal pullman, via Capodimonte, fuori Porta grande del Real Bosco. C’è un bar. Vado a prendere un caffè, magari mi fa venire un’idea nuova, cerco un’ispirazione.
L’idea non mi viene, però chiedo al signore alla cassa. Scusate sapete villa Caccioppoli qual è?
Villa Caccioppoli? No, mi dispiace. Però mi porta all’ingresso e mi indica due signori fermi a chiacchierare che potrebbero saperlo. Hmmm neppure loro hanno un’idea precisa. Forse è la villa che sta più in basso, nella curva prima della Madre del Buon Consiglio, la chiesa grande.
Allora inizio a scendere.
Ma no, a istinto non sono convinto, torno indietro: meglio chiedere qui alla gente del quartiere perché più in basso non ci sono case e chiedere di nuovo non sarà possibile.
Entro nell’edicola all’angolo nel punto esatto dove finisce via Capodimonte e inizia via Ponti Rossi. C’è una signora dietro il banco.
Guardate dobbiamo chiedere a mio marito perché io non sono di Napoli, lui è della zona. E mi porta dall’uomo che stava all’ingresso parlando del più e del meno con una signora.

Lui subito si entusiasma, gli vengono mille idee; ma la prima è guardare su internet con il cellulare. Trova le cose che avevo visto io da casa. Villa Caccioppoli, alcune notizie, ma niente indirizzo, soltanto il nome. Però non si perde d’animo: “Ma io sto nome me lo ricordo”, e continua a cercare; poi telefona a un amico della zona che sape tutt e fatti e secondo lui lo deve per forza sapere.
Nel frattempo dice alla moglie di guardare tra le ristampe di foto d’epoca che tiene in una cartellina nel negozio, dietro al bancone. Lui non perde tempo e intanto parla con quell’amico al cellulare.
Cerchiamo, discutiamo, poi la moglie dice: eccola: e tira fuori una foto gialla con scritto “Napoli-Porta Piccola, Capodimonte, villa Cacciopoli” con una “p” soltanto. L’ha trovata, e mi pare quasi incredibile.

Guardiamo la foto e lui cerca di ricordarsi se ha visto quella forma e dove. Però un dato è importante: Porta Piccola. Allora la casa sta sull’altro lato del bosco, non da questo. Via Capodimonte forse una volta si chiamava anche quella da quell’altro lato.
Ringrazio assai, saluto, entro da Porta Grande, esco dalla Piccola e reinizio a chiedere a quelli su quest’altra sponda.
Dal lato di Porta Piccola
Per adesso nessuno sa molto. Poi vedo un signore anziano seduto lungo il marciapiede e gli faccio la fatidica domanda.

Lui pensa un poco, parla, pensa, ascolta. Poi dice qualcosa. Nel frattempo dal negozio esce una signora, forse la moglie, e iniziano a parlare. Piano piano arrivano, discutendo tra loro, ad una ipotesi, cioè per la signora è un’ipotesi, lui invece è sicuro. Io sbaglio, e mi fido ma solo fino ad un certo punto.
Però seguo la loro traccia. Nel frattempo di nuovo chiedo, un po’ perché l’indicazione che mi hanno dato per me che non sono della zona è chiara ma non del tutto e un po’ per raccogliere magari altri elementi.
Dentro una cartoleria la scena in parte si ripete.
Questa volta è una signora sulla settantina che la ricerca la inizia dal suo telefonino. Quanto è diffuso oggi questo modo di cercare; è il primo posto che ci viene in mente se abbiamo qualcosa che ci manca.

Esco senza molti indizi nuovi. Promettendo di tornare nel caso che la trovo, perché adesso anche loro sono curiosi di sapere se questo posto esiste e dove.
Fuori ad una salumeria, dalla vetrina, una donna mentre passo mi guarda incuriosita. Forse perché ho la macchina fotografica in mano e desto attenzione. Allora entro e chiedo pure a loro.
Bene, mi pare convinta, mi dà un’indicazione precisa e saremmo quasi arrivati. Vado sul posto, lì c’è effettivamente una villa famosa ma dopo poco scopro che non è quella. Però mi indicano il Liceo Sbordone, anche loro sembrano convinti e poi questa collocazione combacia quasi perfettamente con quella che mi aveva dato il signore anziano, all’inizio, lungo il marciapiede. Si trova all’inizio di via vecchia San Rocco, dal lato di via Bosco di Capodimonte che è quella che stiamo risalendo noi.
Vado, entro nel cancello della scuola, chiedo al custode. Sì, la villa è questa qui a fianco. Ci abitano ancora, una persona sola, provate a citofonare.
Eccola, la memoria del quartiere si è ricostruita, è riuscita a convergere, attraverso le teste ed i ricordi delle sue persone, verso questo luogo che gli appartiene. Citofono una volta, due tre, dopo la quarta fotografo dal cancello chiuso e vado via. Ma per ritornare.

Tornando verso casa racconto a quelli a cui avevo chiesto e che erano curiosi, che la villa l’ho trovata, e gli do la posizione: quasi su viale Colli Aminei, proprio attaccata al Liceo Sbordone. Così magari abbiamo avuto anche noi una piccola utilità: di rinfrescare un ricordo del quartiere.
Ritorniamo sul posto
Poi dopo alcuni giorni ci torno. Busso, e la scena sembra uguale, non c’è nessuno che risponde. Chiedo di nuovo al custode della scuola, che ormai si ricorda. Ci consiglia di ritornare tra un poco.
E allora più tardi torniamo. Oh, adesso c’è un signore nel lungo viale d’ingresso, oltre il cancello principale, che sta potando le piante che in questo posto stanno ovunque. Gli facciamo segno da lontano, forse ci stava aspettando.
Si avvicina e gli chiediamo: Questa è villa Caccioppoli?
Sì è questa.
È nato qua il famoso matematico napoletano?
Mah, da quello che mi raccontava sempre mio padre, che curava prima di me questo posto,quando ci abitavano, Caccioppoli era nato in un’altra casa della famiglia. Mi pare… e cita un ricordo vago.
Gli chiediamo se possiamo entrare a vedere com’è adesso la casa. Ma deve chiedere ai proprietari se danno il permesso, per stamattina, giustamente, non si può entrare.
Un po’ di delusione, e un poco di speranza.
Poi, fino ad ora, non ci hanno mai chiamato ad andare a vedere.
Però sapere in quale punto della città ha avuto inizio la storia di quest’uomo ci pare già abbastanza. Possiamo collocare dentro Napoli, l’atmosfera, la luce, l’altezza, il punto da cui ha visto e dal quale lo ha guardato il cielo in quel suo primo giorno.
E poi, se devo dirla tutta, la soddisfazione è che queste giornate ci hanno confermato che chiedere ai napoletani è un bel piacere, e che battono ancora di gran lunga pure internet, quando li metti in rete, anzi è molto più bella la parola insieme.
(Fine seconda parte, continua qui).
Testo e foto Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)
* È accertato da lettere dell’anarchico russo, che la reale paternità delle figlie dichiarate da Bakunin fosse, con Bakunin consapevole e dimostrante grandissima umanità e non attaccamento, dell’avvocato napoletano Carlo Gambuzzi. Vedi ultimo testo tra i Riferimenti sotto.
Riferimenti:
- Ermanno Rea: “Mistero Napoletano”, ed. Einaudi, 1995.
- Romano Gatto, Laura Toti Rigatelli: “Renato Caccioppoli. Tra mito e storia”, ed. Morgana, 2009.
- Michail Bakunin, “Viaggio in Italia”, ed. elèuthera, 2013.
- Atti Accademia Pontaniana, Napoli N.S., Vol. LXIII (2014), pp. 119-162 “Marussia Bakunin: una rilettura aggiornata della vita e della carriera. Nota del socio ord. res. Carmine Colella”









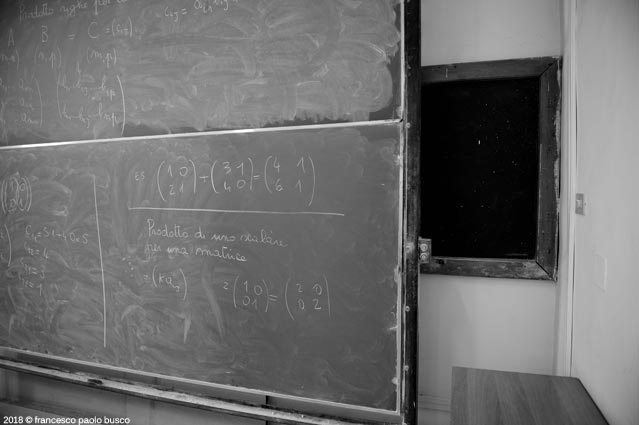







 Sembra che amasse molto starsene qui affacciato a guardare fuori. Oggi forse, con il traffico delle macchine è meno pittoresco, ma se uno prova a ricostruire col pensiero come poteva essere senza il pullman che sta passando adesso, forse si immedesima un poco negli occhi del poeta.
Sembra che amasse molto starsene qui affacciato a guardare fuori. Oggi forse, con il traffico delle macchine è meno pittoresco, ma se uno prova a ricostruire col pensiero come poteva essere senza il pullman che sta passando adesso, forse si immedesima un poco negli occhi del poeta.

 Lasciamo a voi di indagare oltre, a noi per ora è bastato varcare quella soglia e salire i gradini in compagnia del conte.
Lasciamo a voi di indagare oltre, a noi per ora è bastato varcare quella soglia e salire i gradini in compagnia del conte.


 Dalla finestra non si vede il Vesuvio. Ma il monte si sente in questo posto, è alle spalle, ma è come se fosse dappertutto. E doveva essere ancora più forte la sua presenza all’epoca perché era molto più attivo, di notte si vedevano le fiamme.
Dalla finestra non si vede il Vesuvio. Ma il monte si sente in questo posto, è alle spalle, ma è come se fosse dappertutto. E doveva essere ancora più forte la sua presenza all’epoca perché era molto più attivo, di notte si vedevano le fiamme.








 La maggior parte delle opere originali, scritte di persona da lui, e moltissime sue lettere, sono conservate dentro queste sale. Poi potreste passare per Santa Lucia, salire al Pallonetto, perché Leopardi amava mischiarsi con la gente. Dopo potreste scendere a vedere il mare lungo via Caracciolo e andare a cercare la tomba sopra piazza Sannazaro. Visto che vi trovate andate a trovare pure Virgilio, dalla sua tomba si vede il mare e il castello sull’isolotto di Megaride. Il finale migliore, quello che secondo noi avrebbe fatto il poeta stesso, che amava mangiare, è una delle pizzerie della zona, brindando alla vita eterna della poesia bella.
La maggior parte delle opere originali, scritte di persona da lui, e moltissime sue lettere, sono conservate dentro queste sale. Poi potreste passare per Santa Lucia, salire al Pallonetto, perché Leopardi amava mischiarsi con la gente. Dopo potreste scendere a vedere il mare lungo via Caracciolo e andare a cercare la tomba sopra piazza Sannazaro. Visto che vi trovate andate a trovare pure Virgilio, dalla sua tomba si vede il mare e il castello sull’isolotto di Megaride. Il finale migliore, quello che secondo noi avrebbe fatto il poeta stesso, che amava mangiare, è una delle pizzerie della zona, brindando alla vita eterna della poesia bella.